|
di
Donatella Biffignandi del Centro Documentazione Museo dell'Automobile di
Torino,
pubblicato sul mensile "La Manovella" del 21/5/2003.
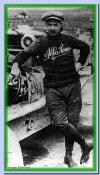 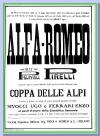 Per
un pilota morire durante le prove, o gli allenamenti, è doppiamente
nefasto: perché la sua vita, il suo nome scompaiono all’improvviso, senza
nemmeno l’epica di una lotta all’ultimo respiro, senza spettatori che
assistano all’estrema arditezza. In prova si muore da soli, e spesso, come
nel caso di tanti piloti, senza capire perché: per fatalità, così si dice
quando non si sa cosa dire. Il giorno dopo, tutti alla linea di partenza
per la gara, come se il pilota appena caduto non fosse mai esistito. Per
un pilota morire durante le prove, o gli allenamenti, è doppiamente
nefasto: perché la sua vita, il suo nome scompaiono all’improvviso, senza
nemmeno l’epica di una lotta all’ultimo respiro, senza spettatori che
assistano all’estrema arditezza. In prova si muore da soli, e spesso, come
nel caso di tanti piloti, senza capire perché: per fatalità, così si dice
quando non si sa cosa dire. Il giorno dopo, tutti alla linea di partenza
per la gara, come se il pilota appena caduto non fosse mai esistito.
Per il milanese Ugo
Sivocci, morto a Monza l’8 settembre di ottant’anni fa durante le prove
per il I Gran Premio d’Europa, non fu proprio così. Alle nove e mezzo di
domenica 9 settembre 1923 i concorrenti cominciano a disporsi sulla linea
di partenza, ma la griglia presenta tre buchi. In seconda fila manca la
vettura n. 6, in quarta la n. 12, in sesta la n. 18: sono i vuoti
lasciati, oltre che da Sivocci, da Ascari e Campari, ritiratisi in segno
di lutto per la morte del loro compagno di squadra il giorno prima. E’
l’ingegnere Nicola Romeo, Consigliere Delegato dell’Alfa Romeo, ad
annunciare il ritiro: “Una sciagura dovuta a slittamento sulla pista
bagnata
 ci priva, a poche ore di distanza dalla grande prova, del nostro
più assennato ed esperto guidatore, del nostro Sivocci. Il dolore per la
perdita del buon Amico e valoroso Collaboratore ci fa dimenticare in
questo momento le ansie divise nel lavoro comune con lo Scomparso…Ma
l’animo dei nostri guidatori non può essere sereno, né sa tentare di
ripassare con mano ferma accanto ci priva, a poche ore di distanza dalla grande prova, del nostro
più assennato ed esperto guidatore, del nostro Sivocci. Il dolore per la
perdita del buon Amico e valoroso Collaboratore ci fa dimenticare in
questo momento le ansie divise nel lavoro comune con lo Scomparso…Ma
l’animo dei nostri guidatori non può essere sereno, né sa tentare di
ripassare con mano ferma accanto al corpo ancora caldo del Compagno.
Perciò, con la stretta al cuore…, ci vediamo costretti a disertare quel
campo di lotta sul quale ritorneremo presto a combattere”. al corpo ancora caldo del Compagno.
Perciò, con la stretta al cuore…, ci vediamo costretti a disertare quel
campo di lotta sul quale ritorneremo presto a combattere”.
 Ugo Sivocci
non è tra i piloti entrati nella leggenda, non diventa il nome ricordato e
scandito dalle folle. Fu di quei piloti preziosi ed oscuri, più
collaudatori che corridori, che arrivano d’improvviso alla notorietà del
grande pubblico grazie ad una vittoria eclatante, in grado di premiare
d’un colpo anni e anni di lavoro svolto infaticabilmente alle spalle di
compagni più noti, loro sì idoli del pubblico. Ugo Sivocci
non è tra i piloti entrati nella leggenda, non diventa il nome ricordato e
scandito dalle folle. Fu di quei piloti preziosi ed oscuri, più
collaudatori che corridori, che arrivano d’improvviso alla notorietà del
grande pubblico grazie ad una vittoria eclatante, in grado di premiare
d’un colpo anni e anni di lavoro svolto infaticabilmente alle spalle di
compagni più noti, loro sì idoli del pubblico.
Nato a Milano nel 1885,
si appassiona al ciclismo sulle orme del più famoso fratello Alfredo. Dal
ciclismo però è difficile trarci da campare, e il giovane Ugo è costretto
a guardarsi intorno e cercarsi un lavoro, lasciando perdere le due ruote.
La sua carriera professionale inizia come collaudatore presso la De Vecchi
Strada & C. (poi De Vecchi & C.), azienda automobilistica milanese che
espone i suoi modelli ai Saloni di Milano e Torino fin dal 1906. Poco
prima della guerra, nel 1913, proprio Sivocci ottiene il primo risultato
sportivo della casa: è secondo di categoria alla Parma – Poggio di
Berceto. Ben più rilevante il risultato della seconda gara a cui partecipa
la De Vecchi: Sivocci, con il meccanico Castoldi, e il suo compagno
Gloria, con il meccanico Marani, si classificano rispettivamente sesto e
terzo alla Targa Florio di quell’anno, al cospetto di vetture ben più
collaudate come Fiat, Ford, Mercedes, Scat. Le riviste dell’epoca non
mancano di sottolineare il lusinghiero risultato, ottenuto in una gara tra
le più dure al mondo (1050 km di strade terribili, che falcidiano i
concorrenti), e correndo su vetture con la più risultato della seconda gara a cui partecipa
la De Vecchi: Sivocci, con il meccanico Castoldi, e il suo compagno
Gloria, con il meccanico Marani, si classificano rispettivamente sesto e
terzo alla Targa Florio di quell’anno, al cospetto di vetture ben più
collaudate come Fiat, Ford, Mercedes, Scat. Le riviste dell’epoca non
mancano di sottolineare il lusinghiero risultato, ottenuto in una gara tra
le più dure al mondo (1050 km di strade terribili, che falcidiano i
concorrenti), e correndo su vetture con la più
 piccola
cilindrata tra tutte e 34 le partecipanti. piccola
cilindrata tra tutte e 34 le partecipanti.
Durante la guerra la De
Vecchi traballa, si trasforma in società anonima e si dedica alla
costruzione dei motori di aviazione. La situazione però è precaria. Nel
1919 una nuova società, la Costruzioni Meccaniche Nazionali, ne acquista
gli edifici in via Vallazze ed evidentemente ne eredita anche gli uomini.
Sarà proprio alla C.M.N. che Sivocci farà uno tra i più importanti
incontri della sua vita: quello con il giovane ed inesperto Enzo Ferrari,
con il quale stringe un’amicizia indimenticabile. Ferrari stesso ricorda
la figura di Sivocci, nel suo libro di memorie: “Quando poi passai a
Milano, alla C.M.N., prima come collaudatore ed in seguito come pilota da
corsa, il salario si fece un poco alla volta più sostanzioso. Fu da allora
che non ebbi più preoccupazioni digiunatorie…Ad aprirmi le porte di Milano
fu Ugo Sivocci, un grande amico. Ci conoscemmo al bar Vittorio Emanuele, a
Milano…Ugo era il capo collaudatore di una fabbrica di automobili e
abitava in una villetta di piazzale Rotole, famoso in quel tempo per un
delitto passionale. La piccola fabbrica, in fondo a via Vallazze, si
chiamava C.M.N., Costruzioni Meccaniche Nazionali…In questa fabbrica
venivano montati su nuovi telai, con materiali
 residuati della Isotta Fraschini, i motori 4 CF…Sivocci mi prese dunque con sé alla C.M.N. e fu
lavorando con lui che avvertii le prime serie avvisaglie di una piccola
vocazione, quella di pilota di automobili da corsa”. Una bellissima
immagine, quella del trentaquattrenne residuati della Isotta Fraschini, i motori 4 CF…Sivocci mi prese dunque con sé alla C.M.N. e fu
lavorando con lui che avvertii le prime serie avvisaglie di una piccola
vocazione, quella di pilota di automobili da corsa”. Una bellissima
immagine, quella del trentaquattrenne Sivocci, dalla carriera solida e
sicura, che nel 1919 nota e prende con sé a lavorare il ventunenne
Ferrari, senza famiglia e senza un soldo, ma già allora caratterizzato da
un qualcosa che lo distingue da tanti altri giovani di belle speranze e
molta fame. Sivocci, dalla carriera solida e
sicura, che nel 1919 nota e prende con sé a lavorare il ventunenne
Ferrari, senza famiglia e senza un soldo, ma già allora caratterizzato da
un qualcosa che lo distingue da tanti altri giovani di belle speranze e
molta fame.
I due cresceranno
rapidamente nella stima l’uno dell’altro. Insieme, si iscrivono alla Targa
Florio del 23 novembre 1919 e partono da Milano sulle stesse macchine
C.M.N. con cui avrebbero dovuto gareggiare. Il viaggio per arrivare in
Sicilia pare non finire mai, e si rivela anche pieno di insidie:
imprigionati da una bufera di neve sull’altopiano abruzzese, sono anche
attaccati dai lupi (messi in fuga, racconta Ferrari, anche dagli spari
della sua rivoltella). Arrivati fortunosamente a Napoli, Ferrari si rende
conto di non potersi permettere il costo del trasporto sul piroscafo
“Città di Siracusa” della sua vettura. “Una specie di solidarietà tra
poveri diavoli – credo che non avessi in tasca più di 450 lire – pose i
facchini al mio servizio, convinse i marittimi a ritardare la partenza,
permise a me, a Sivocci e ad altri piloti di raggiungere Palermo sia pure
a prezzo di una notte di tregenda, con il mare agitato e assalti di cimici”.
Con un viaggio così, è già un miracolo presentarsi alla linea di partenza.
Sivocci e Ferrari ce la fanno, ma
 le avventure non sono finite, Ferrari
finisce addirittura dentro un corteo in onore di Vittorio Emanuele
Orlando, l’uomo “della vittoria mutilata”, e arriva a Palermo quando i
cronometristi e gli spettatori sono già tornati a casa. Sivocci è invece
settimo, non un risultato eclatante, ma il massimo del possibile. le avventure non sono finite, Ferrari
finisce addirittura dentro un corteo in onore di Vittorio Emanuele
Orlando, l’uomo “della vittoria mutilata”, e arriva a Palermo quando i
cronometristi e gli spettatori sono già tornati a casa. Sivocci è invece
settimo, non un risultato eclatante, ma il massimo del possibile.

La loro carriera alla
C.M.N. è agli sgoccioli. L’azienda infatti comincia ad avere il fiato
corto: nonostante il suo impegno nelle corse non era riuscita ad imporsi
sul mercato. Nell’autunno del 1920 Ferrari entra all’Alfa Romeo,
precedendo di poco Sivocci (chissà se stavolta è lui a volere con sé il
compagno!), e i due riprendono a lavorare e correre insieme. Per esempio
alla Parma – Poggio di Berceto dell’8 maggio 1921, dove Sivocci si
classifica secondo di categoria, su un’Alfa 20-30 HP sport, segnando un
ottimo tempo. E’ la gara di cui la stampa (M.A.C.S. del 14 maggio) scrive:
“La seria e meritata vittoria dell’Alfa Romeo. Un’équipe a modello”,
elogiando anche come la squadra milanese si è presentata in gara. “All’intera
équipe era stata data un’impronta omogenea ed elegante, i corridori
indossavano eleganti maglioni scarlatti, le macchine … portavano
carrozzerie ben ideate e finite, verniciate di rosso fiammante, con
radiatori ben sagomati, su cui risaltava dorata la marca Alfa, la parola
d’ordine della vittoria”. Il 29 maggio li aspetta la Targa Florio. I
risultati sono onorevoli, Campari si classifica terzo assoluto, Sivocci
quarto e Ferrari quinto; nelle pubblicità che segue la gara, l’Alfa Romeo
si presenta come la casa “che occupa i primi due posti (con Sivocci
e con Ferrari) nella classifica delle vetture italiane di serie”,
in quanto entrambi correvano con il tipo ES sport di serie. Sono di nuovo
i nsieme
al Circuito del Mugello del 24 luglio, dove la squadra Alfa Romeo,
composta da nsieme
al Circuito del Mugello del 24 luglio, dove la squadra Alfa Romeo,
composta da
 Campari Ferrari e Sivocci, conquista i primi tre posti nella
classifica assoluta, e Sivocci fa segnare il giro più veloce (58’16”, pari
a 66,883 km/h, alla guida di un modello ES sport di serie). Campari Ferrari e Sivocci, conquista i primi tre posti nella
classifica assoluta, e Sivocci fa segnare il giro più veloce (58’16”, pari
a 66,883 km/h, alla guida di un modello ES sport di serie).
Nello stesso anno,
Sivocci si presta alla Fiat per guidare una delle 801 tre litri, in
squadra con Bordino e Wagner. Squadra per modo di dire, composta da piloti
riuniti all’ultimo momento e senza un preciso piano organico di corsa. Non
affiatati tra loro, non abituati alle vetture, in mancanza di un direttore
sportivo che li coordinasse, potevano soltanto perdere, cosa che avvenne.
Con l’esclusione di
questa parentesi, Ugo Sivocci continua a sostenere i colori dell’Alfa
Romeo. Nel 1922
 la squadra, composta da Ascari, Sivocci e Ferrari,
partecipa alla targa Florio, classificandosi ai primi tre posti di
categoria, e ottenendo la Coppa Biglia e la Medaglia d’Oro del Ministero
della Guerra messa in palio per il miglior risultato di équipe. Al
Circuito del Mugello il risultato è invece una débacle: quattro piloti (si
era aggiunto Campari), quattro ritiri. Sivocci si iscrive anche, insieme
ad Ascari (manca invece Ferrari, che da’ forfait all’ultimo momento), al
Gran Premio d’Autunno, corso il 22 ottobre sull’Autodromo di Monza. Con la
sua RL a sei cilindri da tre litri compie una gara regolarissima, senza
neanche arrestarsi per un rifornimento, e si classifica secondo alle
spalle di Dubonnet su Hispano Suiza. Finalmente, nell’aprile del 1923, il
grande colpo: la vittoria assoluta sul campo di gara più difficile del
mondo, la Targa Florio. Sivocci e Ferrari sono partiti uno dopo l’altro a
soli cinque minuti di distanza, entrambi su Alfa Romeo RL di cilindrata
appena superiore alla restanti Alfa in gara: 3100 cc anziché 3000
(escamotage per poter iscrivere le vetture in categorie diverse, e
cogliere più opportunità di vittoria). Già dal terzo giro, su quattro
complessivi, la lotta è ristretta tra Minoia su Steyr, e i due compagni di
squadra Sivocci ed la squadra, composta da Ascari, Sivocci e Ferrari,
partecipa alla targa Florio, classificandosi ai primi tre posti di
categoria, e ottenendo la Coppa Biglia e la Medaglia d’Oro del Ministero
della Guerra messa in palio per il miglior risultato di équipe. Al
Circuito del Mugello il risultato è invece una débacle: quattro piloti (si
era aggiunto Campari), quattro ritiri. Sivocci si iscrive anche, insieme
ad Ascari (manca invece Ferrari, che da’ forfait all’ultimo momento), al
Gran Premio d’Autunno, corso il 22 ottobre sull’Autodromo di Monza. Con la
sua RL a sei cilindri da tre litri compie una gara regolarissima, senza
neanche arrestarsi per un rifornimento, e si classifica secondo alle
spalle di Dubonnet su Hispano Suiza. Finalmente, nell’aprile del 1923, il
grande colpo: la vittoria assoluta sul campo di gara più difficile del
mondo, la Targa Florio. Sivocci e Ferrari sono partiti uno dopo l’altro a
soli cinque minuti di distanza, entrambi su Alfa Romeo RL di cilindrata
appena superiore alla restanti Alfa in gara: 3100 cc anziché 3000
(escamotage per poter iscrivere le vetture in categorie diverse, e
cogliere più opportunità di vittoria). Già dal terzo giro, su quattro
complessivi, la lotta è ristretta tra Minoia su Steyr, e i due compagni di
squadra Sivocci ed
 Ascari. La vittoria sembra profilarsi certa per
quest’ultimo, in prima posizione a pochi metri dal traguardo. Invece
accade l’imprevedibile. La vettura di Ascari si blocca a duecento metri
dalla fine, i meccanici si affannano a farla ripartire, quando ci riescono
la concitazione è tale (Ascari è ancora primo) che saltano tutti in
macchina e si presentano insieme al traguardo: squalificati. Allora Ascari
gira la macchina, torna al punto incriminato, i meccanici volano giù dalla
vettura, riparte da solo a razzo: ma intanto gli piomba alle spalle Sivocci, lo oltrepassa e si classifica primo, dopo sette ore, diciotto
minuti e tre secondi di corsa. Ascari. La vittoria sembra profilarsi certa per
quest’ultimo, in prima posizione a pochi metri dal traguardo. Invece
accade l’imprevedibile. La vettura di Ascari si blocca a duecento metri
dalla fine, i meccanici si affannano a farla ripartire, quando ci riescono
la concitazione è tale (Ascari è ancora primo) che saltano tutti in
macchina e si presentano insieme al traguardo: squalificati. Allora Ascari
gira la macchina, torna al punto incriminato, i meccanici volano giù dalla
vettura, riparte da solo a razzo: ma intanto gli piomba alle spalle Sivocci, lo oltrepassa e si classifica primo, dopo sette ore, diciotto
minuti e tre secondi di corsa.
Una vittoria un po’
piratesca, ma pur sempre una vittoria di dimensione internazionale, che
finalmente consacra Sivocci grande pilota, e lo trae dal limbo degli
eterni secondi. Compaiono per la prima volta, sulla stampa, degli articoli
su di lui, dove viene descritto di “una calma ed una prontezza di
decisione straordinarie, che fanno di lui uno dei più regolari guidatori
del momento”. Ci si aspetta molto da lui per il prossimo traguardo: il
primo Gran Premio d’Europa, in calendario per domenica 9 settembre, per il
quale l’Alfa Romeo intendeva far esordire la sua nuova vettura, la P1. Dal
16 agosto la squadra al completo è sulla pista di Monza per le prove. Le
riviste ne riportano i risultati (toccati più volte i 180 km/h) e
Auto-Moto-Ciclo pubblica anche una carrellata dei migliori piloti del
momento: tra questi, Ugo Sivocci, anch’egli tra i grandi campioni. Il suo
viso segnato, con tanto di coppola e vistosi baffoni, lo fanno sembrare
più vecchio di quel che è, trentotto anni. E’ inevitabilmente “un pilota
della vecchia guardia”. Una vecchia guardia onesta e pulita, che lavora in
prima linea ma non disdegna il lavoro delle retrovie, con grande rispetto
per la macchina, prestandosi la’ dove si è utili: che si tratti di fare il
collaudatore, il meccanico, il pilota, il revisore. E’ l’uomo capace di
fare squadra, di trasformare una compagine di talenti individuali in un
gruppo affiatato e rodato. La sua morte, avvenuta l’ultimo giorno degli
allenamenti, sabato 8 settembre, raggela l’animo di tutti quelli che
lavorano con lui. Una fotografia, pubblicata in queste pagine, ritrae la
sua macchina danneggiata, mentre viene caricata sul camion per essere
portata via. Campeggia sul fianco il n. 17, esattamente lo stesso numero
della vettura con cui si era ucciso l’anno prima un altro promettente
pilota italiano, Biagio Nazzaro, nipote del famoso Felice. Al di la’ della
superstizione, un’immagine triste, che suggella la vita di un uomo buono.
Donatella Biffignandi |